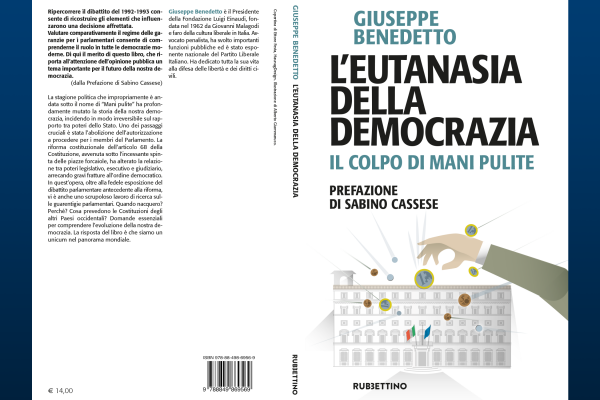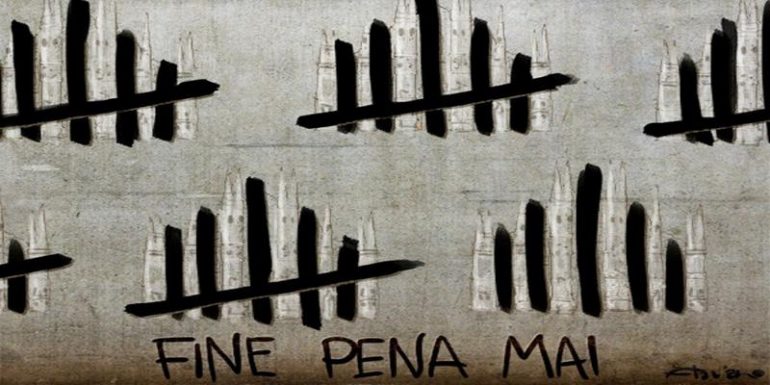Commento a Cass. Pen. Sez. V. Sent., (ud. 14.9.2020) 14.10.2020, n. 28559
1. Il caso deciso
Al fine di una completa comprensione della quaestio iuris decisa dalla pronuncia annotata, appare utile illustrare i fatti sottesi alla questione di diritto con la quale i giudici di legittimità sono stati chiamati a confrontarsi.
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, aveva confermato l’affermazione di penale responsabilità di un imputato per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto, commessi in un centro commerciale attraverso la cosiddetta tecnica dell’ariete, ovverosia sfondando le porte antipanico con un’autovettura.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il difensore dell’imputato medesimo, lamentando il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Nello specimen, a detta del difensore, il puntcum dolens della parte motiva della sentenza di appello consisteva nell’aver dedotto, attraverso un ragionamento circolare, che l’imputato avesse commesso il reato ad esso ascritto, sol perché agli atti risultava un’unica prova indiretta, indiziaria, ovvero la circostanza che la sua utenza telefonica si era agganciata ad una cella ubicata in luoghi limitrofi a quelli del locus commissi delicti. Facendo leva sull’anzidetta doglianza, il ricorrente criticava poi l’ulteriore tassello motivazionale a cui aveva fatto ricorso la Corte di Appello; la sentenza di condanna veniva infatti motivata – potrebbe dirsi quasi “lombrosianamente” – deducendo la responsabilità dell’imputato pure dalla mera circostanza che egli era stato coinvolto in altro furto, commesso sempre con la tecnica dell’ariete, ciò che si trasformava in elemento di ulteriore sospetto nei suoi confronti.
I Giudici della nomofilachia accoglievano le doglianze prospettate dal ricorrente, rilevando come la Corte territoriale non avesse fatto buon governo delle regole di valutazione degli indizi, avendo riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato, da un lato esclusivamente attraverso la valorizzazione di un solo indizio, ovvero la localizzazione, dall’altro valutando come prova critica un mero sospetto, cioè il coinvolgimento in un furto commesso un anno prima con modalità simili.
2. Il “sillogismo giudiziario” e la regola di valutazione degli indizi
Il principio di diritto sancito dalla sentenza che si annota – che a parere di chi scrive costituirebbe un’ovvietà – è, a ben vedere, espressione dei principi fondamentali in materia di motivazione dei provvedimenti giudiziari e di valutazione della prova indiziaria. L’organo giudicante non può dedurre, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato da un unico indizio. Al contempo, è imposto al giudice un serrato onere motivazionale nell’illustrazione del ragionamento logico seguito. Ed infatti, i criteri adottati ed i risultati acquisiti non possono trovare fondamento in un unico indizio, né tale mancanza può essere supplita dalla valorizzazione di elementi privi di rilievo probatorio, quale è il mero sospetto, di per sé sguarnito di un’univoca capacità dimostrativa rispetto alla ricostruzione di un fatto storico. Invero, le congetture, le illazioni, id est i sospetti, non possono essere utilizzati dal giudice nella costruzione di quello che è stato efficacemente definito un “sillogismo giudiziale”. È oltremodo evidente che i due principi – la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la regola di valutazione degli indizi – siano indissolubilmente destinati a coesistere e ad intersecarsi tra loro in situazioni simili a quella sub specie.
L’episteme di queste vere e proprie regole di civiltà giuridica, come noto, risale addirittura al Beccaria, il quale distinguendo tra prove “perfette” e “imperfette” affermava: «possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo per l’unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia». Il concetto espresso oltre due secoli fa dall’illuminista milanese è oggi scolpito nel testo dell’art. 192, commi, 2 e3 c.p.p., sul quale la Cassazione è stata più volte chiamata a pronunciarsi, senza mai mettere in dubbio il significato della littera legis. Volutamente, utilizzando il plurale – indizi, gravi, precisi e concordanti – il legislatore ha accolto quella tradizione secolare di valutazione delle prove indiziarie, caratteristica indubitabile del rito accusatorio.
La genesi dei criteri di valutazione degli indizi è, dunque, da ricercare nella distinzione di essi rispetto alle prove. Come è noto, nelle prove il fatto da provare è immediatamente dedotto dal giudice attraverso la rappresentazione che di esso ne fa la fonte. Viceversa, nell’indizio, il fatto storico è provato attraverso un ulteriore passaggio logico che si frappone tra la fonte della prova critica ed il fatto da provare. Solo una legge scientifica ovvero una massima di esperienza consente al giudice di ricollegare l’indizio al fatto. Questo tipo di ragionamento, se l’indizio è isolatamente considerato, è inevitabilmente debole dal punto di vista logico, poiché il fatto indiziante di norma è significativo di una moltitudine di fatti non noti.
Appare emblematica in tal senso la preoccupazione espressa dal legislatore codicistico nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale vigente, ove viene affermata la necessità «di una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico, non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva della prova». I requisiti quantitativi e qualitativi fissati dal codice in materia di valutazione degli indizi, nella visione del legislatore, avrebbero dovuto avere la funzione di arginare la discrezionalità del giudice.
La regola valutativa prevista dall’art. 192, comma 2, c.p.p., come insegnano le Sezioni Unite, conferisce rilevanza al singolo indizio solo se è corroborato da altri (almeno due) elementi indizianti, purché tutti confluiscano verso un’unica ricostruzione dei fatti da provare. Ed invero, è proprio questo legame indissolubile che lega ogni indizio all’altro che deve essere illustrato nella parte motiva della sentenza; così il giudice ricostruisce un ben preciso percorso logico «come quando si salta da un masso all’altro e poi un altro ancora, per passare da una sponda all’altra del fiume senza cadere in acqua», fino ad approdare alla prova logica del fatto, quella che il Beccaria definiva una “prova perfetta”. È in questi termini che può parlarsi di convergenza del principio dell’obbligo di motivazione con la regula iuris di valutazione degli indizi fissata dall’art. 192, comma 2, c.p.p.. Norma questa che, lungi dal costituire eccezione al libero convincimento, né è la più alta espressione.
3. Ragionevole dubbio e cultura del sospetto
Nella vicenda in commento, balza ancora più agli occhi come la Corte di Appello di Milano, abbia costruito il suo ragionamento logico riscontrando l’unico indizio a carico dell’imputato solo con un mero sospetto. La critica più incisiva che la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione muove nei confronti della Corte territoriale riguarda proprio l’aver confuso una mera congettura con un indizio. Sul punto è lapidaria la distinzione concettuale: il sospetto è una mera ipotesi soggettiva, non riconducibile in alcun modo – nemmeno con una massima di esperienza – alla commissione di un reato, mentre, gli indizi sono il risultato di un ragionamento inferenziale, attraverso il quale, da un fatto noto si deduce, con alta ed oggettiva probabilità razionale, l’esistenza del fatto da provare. In altri termini, i sospetti, in quanto tali, possono trovare riscontro solo nella mente dell’inquirente e del giudice e non possono mai costituire presupposto argomentativo della motivazione di una sentenza. A ciò si aggiunga che pure l’indizio, se equivoco, non consente di escludere possibili ricostruzioni alternative, poiché non è “grave”; non basta, infatti, che gli indizi siano più di uno, ma è necessario anche che i fatti noti – le singole circostanze indizianti – siano già di per sé sufficientemente provate. Come è stato autorevolmente affermato, se la circostanza indiziante non è sufficientemente provata «si corre il pericolo di costruire un castello di argomentazioni logiche che rischia di franare dalle fondamenta».
A ciò, a ben vedere, si riferisce la Suprema Corte ove si preoccupa di precisare che la valutazione delle prove indiziarie è di natura bifasica: prima il giudice è tenuto a verificare il livello di precisione e gravità di ciascun indizio, isolatamente considerato, successivamente, deve esaminare unitariamente tutte le circostanze emerse e valutarne la concordanza. In altri termini, ciò sta a significare che deve essere possibile escludere qualsiasi ricostruzione alternativa e poter così affermare la penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. I sospetti, da un punto di vista logico, non consentono al giudice di effettuare il c.d. tentativo di smentita, operazione indispensabile, finalizzata a vagliare l’attendibilità di possibili ricostruzioni alternative rispetto ai fatti contestati all’imputato. Viceversa, gli indizi, se sufficientemente provati, assumono una diretta dimensione oggettiva e, pertanto, possono essere il fondamento del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, riscontrabile da chiunque nelle motivazioni della sentenza. Al contrario, il sospetto, pur se suffragato da circostanze oggettive, può, tuttalpiù, essere motivo per compiere atti di indagine, ad esempio nel caso in cui dichiarazioni rilasciate da una persona informata indirizzino le indagini verso un nuovo “bersaglio” prima ignoto.
La regola di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p. appare inevitabilmente connessa ai criteri di valutazione degli indizi ed è proprio nei processi indiziari che trova la sua più alta consacrazione pratica. Come è noto il termine “ragionevole” sta a significare che il dubbio deve essere comprensibile da una persona razionale, esso ha natura oggettiva e negli stessi termini il giudice dovrà necessariamente tenerne conto nella motivazione della sentenza. Pertanto, il dubbio è ragionevole – poiché all’evidenza non oggettivamente riscontrabile – ogniqualvolta la prova di un fatto viene dedotta dal precedente coinvolgimento in altro reato ovvero semplicemente visionando il certificato del casellario giudiziale. Giudicare l’imputato attribuendo rilevanza alla sua storia passata significherebbe valutarne la penale responsabilità sulla base di un pre-giudizio, ovvero procedere per tipi di autori criminali e non per tipi di fatti criminosi.
Venendo ad un profilo di analisi, al tempo stesso più ampio e di sistema, appare quanto mai preoccupante la tendenza di parte della magistratura –riscontrabile non solo nel caso descritto dalla sentenza che si annota – di procedere per “sospetti”. Se si tiene, quindi, in considerazione in che termini influisca la regola di giudizio nella valutazione delle circostanze indizianti, deve rilevarsi come dopo oltre quattordici anni dalla legge n. 46 del 2006, il c.d. “B.A.R.D.” appare essere in qualche modo maldigerito; motivare le sentenze attraverso “congetture e sospetti”, significa aggirare il quantum di prova richiesto dal codice di rito, poiché ciò che risiede nella mente del giudicante non potrà mai colmare lo standard probatorio del processo penale.
Del resto, non sono lontani gli anni in cui, in noti casi di cronaca giudiziaria, veniva invocata la c.d. teoria della convergenza del molteplice, secondo cui un indizio, non grave e non preciso, diverrebbe sufficiente, se integrato con altre circostanze, parimenti, non gravi e non precise, ma convergenti nell’individuazione della responsabilità dell’imputato. Solo qualche anno fa, la Corte di Assise di Appello di Firenze condannava Amanda Knox e Raffaele Sollecito, affermandone la penale responsabilità, da un lato ritenendo che i singoli indizi non fossero rassicuranti e non costituissero una prova certa, dall’altro, tuttavia, riconoscendo sussistente la prova logica dei fatti contestati, poiché tutti gli elementi, unitariamente valutati, potevano ritenersi possibili o probabili. Soltanto nel 2015, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando i principi costituzionali di cui agli artt. 27, comma 2, e 111, comma 6, Cost, era costretta ad affermare che «il ricorso alla logica ed all’intuizione non può supplire in alcun modo a carenze probatorie o ad insufficienze investigative». La convergenza di più elementi, tra cui, per ipotesi il coinvolgimento dell’imputato in altro delitto, non aumenta la probabilità logica dell’ipotesi dell’accusa, infatti, il sospetto può esprimere ciò che avviene il più delle volte secondo un apprezzamento del tutto personale dell’inquirente o del giudicante, ma non ciò che nella realtà è avvenuto; in questa tipologia di ragionamento difetterebbe quell’alta “credibilità razionale” richiesta dalle Sezioni Unite.
In conclusione, pare il caso richiamare le parole di un magistrato, il cui insegnamento, richiamato ad ogni pié sospinto, mostra, a quasi trent’anni dalla sua morte, di non essere evidentemente stato compiutamente compreso: “la cultura del sospetto non è l’anticamera della verità: la cultura del sospetto è l’anticamera del khomeinismo” (G. Falcone).
Penalista, abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dà vita nel 2004 allo studio che porta il suo nome, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel campo del diritto penale, ulteriormente specializzandosi poi nelle tematiche del diritto penale dell’impresa.
L’esercizio della professione non gli impedisce di continuare l’attività universitaria: conseguito il dottorato di ricerca, è stato per oltre dieci anni docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Firenze.
È docente a contratto di Diritto delle Prove Penali e Criminologia presso l’Università Mercatorum di Roma e Direttore e Coordinatore del Master Universitario di I livello in Anticorruzione: un nuovo modello di etica pubblica. Risposte ordinamentali e nuovi protagonisti presso la Link Campus University di Roma.
Accanto alle molteplici pubblicazioni scientifiche, si segnalano numerosi convegni che lo vedono come relatore.
È inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea).
E’ stato fiduciario in materia penale, su tutto il territorio nazionale, del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori di polizia) ed è oggi il coordinatore del Dipartimento Affari Legali della UIL Sicurezza.
È il responsabile dell’Ufficio Legale di USIP – International Police Sports Union – Police Games Milano 2019.
Attualmente insegna Diritto Processuale Penale presso l’Università IUL.