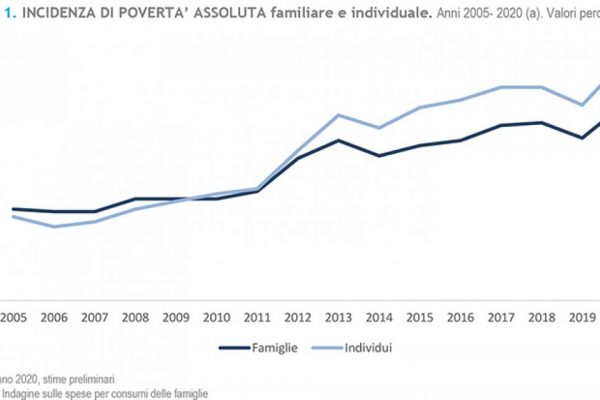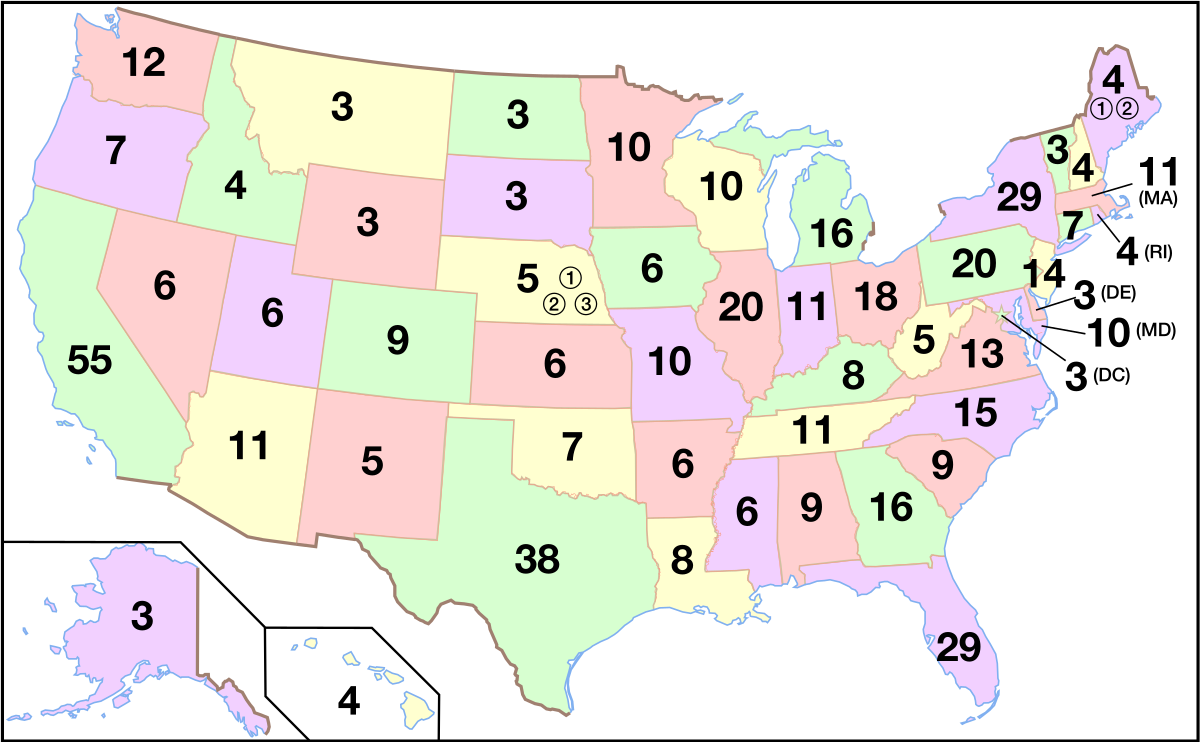Cicerone ci ricorda le quattro virtù che l’espressione deve possedere (virtutes elocutionis): aptum (appropriatezza), puritas (correttezza lessicale e grammaticale), perspicuitas (chiarezza) e ornatus (eleganza).
Se guardiamo indietro nel tempo, specie nella prima repubblica, una regola non scritta in politica era evitare il più possibile l’utilizzo della parola “Io” durante un comizio. Regola non scritta che diventava divieto assoluto per l’attacco del discorso da offrire alla popolazione accorsa all’ascolto comiziale.
Pare assurdo pensare come questo modo di comportarsi politicamente, oggi costituisce invece uno dei principi cardine della comunicazione efficace.
A ben vedere si tratta di qualcosa che dai tempi di Cicerone (ma anche nel mondo socratico) si trascina sino alla contemporaneità. Si specifica la parola: si trascina.
Il motivo sta nell’evoluzione della lingua pubblica, non quella corrente (sono concetti differenti), dettata dall’approssimata educazione alla politica.
Senza sfociare nell’empirismo, è percepibile come (generazionalmente parlando) sia cambiata e mutata la qualità di elocutio della massa degli attori politici soprattutto: palpabile tutto ciò da quando i partiti hanno abdicato alla funzione formativa della classe dirigente, all’educazione civica dei sostenitori, all’essere d’ammirevole contenitore di sapere per chi volesse chiedere lumi circa qualcosa.
L’esempio classico che viene in mente è quando al termine dei comizi, Aldo Moro veniva avvicinato dalla folla non solo per una stretta di mano ma soprattutto per chiedere di “quel problema” che ci può dire Onorevole? Si creavano così le interazioni politico-cittadine il cui linguaggio del comiziante doveva esser forbito ma puntare a trasmettere un concetto semplice; cosa che, invece, la contemporaneità ci consegna in segno discutibile: la democrazia si sta abituando al banalismo del “non dire” cioè “all’IO sono come TE”.
Questo processo d’immedesimazione tra politico e cittadino è dannoso per due motivi: il primo perché non genera ammirazione tra il delegante (chi vota) e il delegato (chi si impegna a rappresentare); il secondo perché il politico, in quanto presumibilmente più industriato alla risoluzione dei problemi che il cittadino non può solo, deve aggiudicarsi la stima quale elemento durevole del rapporto elettorale.
La volatilità dei partiti, l’aleatorietà delle maggioranze, l’incertezza dell’impegno politico delle persone ha generato lo scemare dei processi di stima che sono relazioni necessarie sociologicamente per il fine elettorale stesso.
Il risultato di questa falla del linguaggio è il come si sia giunti a legittimare e considerare attendibile un impianto politico basato sul monovocabolismo: il memorabile “vaffa”.
Il pensiero, se vaffalogico, non è più tale, ma diventa la predizione politica del “NON voto” nella misura in cui esso ha rappresentato e rappresenta proprio quel distacco voraginoso tra chi va sul palco e chi dal palco trae consapevolezza per andare a votare.
Il retroterra di quest’ultimo passaggio consiste nel fatto che quando nessuno più va ai comizi (social a parte), quando nessuno più si affaccia in una sede di partito, quando nessuno più chiede conto alla politica di quel determinato problema, ma solamente si sfoga su di essa come se fosse ad un incontro di boxe, allora, non ha perso il linguaggio, ma hanno perso le relazioni umane.
D’altronde il linguaggio, anche in politica, è o non è funzionale se esistono le relazioni? Gli elettori di oggi sono affamati di ascolto? La politica di oggi è affamata di persuasione?
Sono domande complementari perché essere politicamente affamati è cosa diversa dall’aver fame politica. Nel primo caso la parola buona è il perno, nel secondo caso subentra la corruzione mentale: cioè il monovocabolismo docent.
Torna utile, su questo concetto, Cicerore (De Oratore 3, 14, 53):
“Quale oratore suscita un brivido negli uomini?
Quale oratore è osservato con ammirato stupore?
Quale oratore strappa grida di ammirazione?
Quale oratore è ritenuto un dio tra gli uomini?
L’oratore i cui discorsi sono chiari, ordinati, copiosi, splendidi sia per contenuto sia per forma; l’oratore che anche nella prosa crea un ritmo quasi poetico: questo è lo stile che io chiamo ornato.
L’oratore che pronuncia la sua orazione adeguandosi all’importanza dei fatti e delle persone merita lode per quel genere di dote che io chiamo convenienza e congruenza”.
Ecco, che democrazia siamo diventati per aver ammirato un Vaffa?
L’immedesimazione politica ha ucciso il linguaggio della democrazia, nella democrazia, per la democrazia. Toccando così la pancia del popolo.
Per questo, una volta, i partiti avevano il ruolo cosciente e consapevole (che dovrebbero avere tuttora come vuole la Costituzione) di dover addolcire il malessere, di dover disinnescare le micce repulsive nella società fungendo da figure di traduzione tra il bisogno e il normabile.
Perché quando le norme diventano l’oggetto del bisogno stesso possiamo stare certi che la corsa elettorale non è più a chi ha il programma migliore e davvero fattibile, ma a chi la spara più grossa.
Avvocato, saggista, già vice presidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico.
Delegato italiano (under 40) al G20 Amburgo 2022 industria, imprese e sviluppo economico organizzato da compagini industriali/imprese dei Paesi partecipanti con Ministero economia tedesco.
Docente aggiunto a.c. in Diritto tributario dell’impresa e Diritto processuale tributario – Dipartimento Economia, Management, Istituzioni presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Componente di cattedra in “Diritto e spazio pubblico” – Facoltà di Scienze Politiche presso Università degli studi internazionali di Roma.
Componente del tavolo di esperti per gli studi sul “reddito universale” – Dipartimento di Scienze Politiche Università internazionale per la Pace dell’ONU (sede di Roma).
Direttore del Dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari – Università Federiciana popolare.
Consigliere della “Commissione Etica ed Affari Legali” in seno al Comitato tecnico legale della Federazione Italiana E-Sports.
Componente del comitato scientifico della rivista @Filodiritto per l’area “socio-politica”.
Founder di @COLTURAZIONE
Pubblicazioni principali:
– “Opere edilizie su suolo privato e suolo pubblico. Sanzioni penali e profili costituzionali” (Altalex editore, 2016);
– “I sistemi elettorali in Italia: profili evolutivi e critici” (Pubblicazioni Italiane, 2018 – testo in collettanea);
– “L’inedito politico costituzionale del contratto di governo” (Aracne editrice, 2019);
– “Dal contratto di governo al governo da contatto” (Aracne editrice, 2020);
– “Nessuno può definirci. A futura memoria (il tempo del coraggio). Analisi e riflessioni giuridiche sul D.d.l. Zan” (Aracne editrice, 2021 – testo coautoriale);
– “Amore e Politica. Discorso sulla Costituzione e sulla Dignità dell’Uomo” (Aracne editrice, 2021);
– “Draghi Vademecum. La fine del governo da contatto. Le sfide del Paese tra dinamiche politiche e districamenti sul fronte costituzionale” (Aracne editrice, 2022).
Ultima ricerca scientifica – “La guerra nella Costituzione ucraina” – pubblicata su Alexis del GEODI (Centro di ricerca di Geopolitica e Diritto Comparato dell’Università degli studi internazionali di Roma).
Scrive in borderò per Italia Oggi e La Ragione ed è autore su La Voce di New York (columnist), Il Riformista, Affari italiani (editoriali), Formiche, Il Sole 24 Ore, Filodiritto (curatore della rubrica Mondovisione), Cercasi un Fine e sul blog di Fondazione Luigi Einaudi.