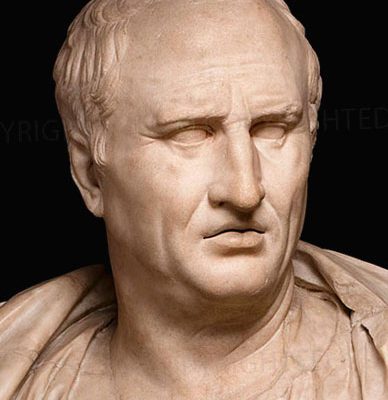A più di un mese dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, mentre Biden ripete che in gioco ci sono le democrazie del mondo, la risposta della nostra politica è pressoché allineata. Al netto di Sinistra Italiana e pochi altri fuori dal coro e di Conte che definisce “impensabile un riarmo”, l’Italia è tra i paesi che hanno deliberato un aumento della spesa militare. Nella seduta scorsa la Camera ha approvato, infatti, il disegno di legge di conversione del d.l. 25 febbraio 2022, n. 14, noto come Decreto Ucraina. È ormai certo però che il Governo porrà la fiducia al Senato, per il provvedimento che preannuncia un incremento delle spese di Difesa intorno al 2% di PIL.
Intanto la resistenza degli ucraini continua. La notizia che lascia sperare arriva in queste ore da Istanbul e apre lo spiraglio ad una tregua che ancora non c’è. Malgrado i negoziati, Kiev resta sotto i raid.
La guerra sul terreno è un quadro fisso: devastazione, palazzi sventrati, file di sfollati. La narrazione poi è parte del conflitto.
Ma davvero alla guerra non c’è altra via che la guerra? La domanda è di quelle che risuonano in testa come tamburo battente in queste settimane, per questo giriamo l’interrogativo a Salvatore Vasta, professore associato di Storia della filosofia contemporanea all’Università degli Studi di Catania, autore di numerosissimi saggi e di una importante attività di ricerca.
Qual è il pensiero del filosofo su questo conflitto. Era davvero inevitabile?
Non possiamo negare al conflitto una sua oggettività. Mettendo per un attimo da parte la questione che in una guerra ci sono sempre almeno due contendenti con qualcuno che sta dal lato “giusto” e qualcun altro da quello “sbagliato”, per quanto si possa essere refrattari all’idea, c’è da sempre chi sembra riservare all’aggressione programmata e allo scontro cruento una modalità prioritaria per affrontare e risolvere controversie con altri uomini. La guerra è una parte integrante della storia dell’umanità.
Vuol dire che dobbiamo arrenderci e riconoscere alla guerra un carattere di necessità ed ineluttabilità?
No, questa consustanzialità non deve mai farci pensare che abbia le caratteristiche della necessità. Non è assimilabile a una legge di natura. Una cosa è teorizzarla letterariamente, studiarla, comprenderne le ragioni, altra cosa è la sua giustificazione o la sua attuazione.
La filosofia cosa ci dice in proposito?
La filosofia, per sua costituzione epistemologica, non può accettare gli ultimi due punti di vista. La guerra la fanno e la vogliono gli uomini. È agita da qualcuno e in genere ogni aggressione è atto volontario, non riconducibile alla casualità. Seguendo questo semplice ragionamento, nessun conflitto può essere considerato in linea di principio necessario e ineluttabile.
Secondo il filosofo ucraino Minakov, Putin che oggi sembra il vincitore in pochi anni trasformerà la Russia in un deserto. Di lui, appena tre anni fa, Yuval Noah Harari nel suo ultimo libro “21 Lezioni per il XXI secolo” scriveva che “non è né Gengis Kahn né Stalin e sembra sapere meglio di chiunque altro che con quella forza militare non può andare lontano nel XXI secolo, perché per avere successo una guerra oggi deve restare un conflitto di impatto contenuto”. Diversamente, quello che sta accadendo oggi, ci mette di fronte al pericolo che questa guerra superi i confini e si trasformi nella terza guerra mondiale.
Professore, come leggiamo dunque l’invasione dell’Ucraina?
Minakov è convinto che quella putiniana sia una strategia supportata da una componente orientata ai cascami di una certa tradizione di interpretare il potere. La carriera di Putin in tempi di post-comunismo ne è una carta di identità adamantina.
Il putinismo, se di questo si tratta, da un lato è una modalità aggressiva e autocratica di gestire il potere economico-politico, creando non un capitalismo di stato, ma un capitalismo di cui lo stato rappresenta una semplice mediazione, una sorta di club esclusivo al quale si può appartenere per cooptazione. Dall’altro lato esso poggia sull’assunto che la Russia non è, né dovrà mai essere, parte di quell’idea illuministica di razionalità europea che, anche con qualche contraddizione, ha orientato l’Europa verso i traguardi della laicità (il “portmanteau” che ci ha permesso di guardare alla libertà e all’uguaglianza o ai diritti nel loro complesso come forme essenziali, attraverso le quali una collettività esprime il proprio desiderio ad autodeterminarsi).
A queste potranno aggiungersi poi molte altre considerazioni, di ordine certamente geopolitico ed economico, ma non vi è ragione alcuna per non credere che Putin voglia sottolineare questa diversità a tutti i costi, anche correndo il rischio “stupido” di iniziare qualcosa della quale non è possibile conoscere l’esito. Tutto si giocherà su quanto sapremo accettare e condividere questa nuova parentesi storica, temo abbastanza lunga, di riaccomodare il nostro stile di vita a una sobrietà che negli ultimi decenni abbiamo dimenticato.
Fuori da ogni previsione, può trattarsi – come sostiene lo storico israeliano – di un errore di valutazione? Siamo di fronte alla “stupidità umana” che Harari ritiene essere una delle forze decisive (e forse sottovalutate) della storia?
Putin è l’ennesimo giocatore che si siede al tavolo della storia pensando di giocare da solo la partita. Non lo fa immaginando di prevedere le mosse dell’avversario rispettandolo, ma giocando con regole che sono soltanto le sue, fatte anche di imprevedibilità. In un contesto del genere, o si adeguerà alle regole condivise del gioco o verrà rimosso dal tavolo. In ciò potrebbe tradursi quella “stupidità” di cui parla Harari, perché il tallone di Achille della invincibilità e della sicurezza di Putin (come di chiunque abbia voglia di far guerra alla Putin), non risiede in ciò che l’avversario ha e tu non vedi, ma in ciò che ti rifiuti di attribuirgli, pur avendolo sotto gli occhi.
Tra le reazioni scomposte di molti, in queste che sono state settimane difficili, non possiamo tralasciare il tentativo dell’università Bicocca di Milano di cancellare il corso su Dostoevskij.
Ciò che è accaduto all’Università di Bicocca, stando almeno a quanto sappiamo, lo annovero tra quelle forme di stimolo-risposta non ponderate: accade quando si vuol evitare che un probabile evento inneschi delle critiche e nel cercare di prevenirlo si procurano invece, dall’interno e in anticipo, conseguenze di più forte intensità.
Alla base cosa c’è?
Il pregiudizio è quasi sempre alla base dell’errata valutazione della realtà. Del pari, l’idea massimalista secondo la quale un tema possa essere trattabile o meno, a seconda di una determinata situazione storica contingente, mi sembra assolutamente poco condivisibile, soprattutto se parliamo di un corso universitario. Ciò sposta il discorso su un altro livello e ci fa capire come ogni eventuale “raccomandazione” nel leggere la realtà sia meglio ascriverla ai dubbiosi, piuttosto che agli zelanti.
Preferire il dubbio piuttosto che le certezze incrollabili, insomma, è il suggerimento. La censura nella forma dell’epurazione – che è poi la massima espressione del divieto e infine del controllo – siamo abituati a riconoscerla e anche a respingerla. Ma siamo certi che in questo momento non ne serpeggi un’altra, più difficile da osteggiare? Sono le fake news, è la falsa informazione, la censura del nuovo ventennio?
Sul rapporto tra censura e fake-news e sul ruolo che queste ultime stanno assumendo come forma più soft (ma sicuramente più pervasiva) nel dominare il campo dell’informazione, sono d’accordo. Anzi, dirò di più. Laddove la censura opera un vero e proprio blocco dei flussi di informazione a monte, sostituendoli con altri “di parte”, e il processo è facilmente scoperchiabile, nel caso della fabbrica della mistificazione, il livello è più sofisticato perché opera nel mezzo stesso dei canali e dei contenuti comunicativi. In questo maremagnum è semplice riorientare le credenze di chiunque, soprattutto se le poche che si posseggono non sono “vere e ben giustificate”.
Siamo di fronte al modo con cui questa nuova forma, ormai non più sperimentale, che io definisco di “co-informazione latente” manifesta uno stato di nascondimento permanente nei regimi democratici.
Stiamo parlando di differenze tra democrazia e regime, insomma?
Esatto, a differenza dei regimi autocratici o dittatoriali nei quali si preferisce da sempre (e soprattutto internamente) l’uso della censura perché di più semplice gestione anche economica, in quelli democratici non è desiderabile usare ciò che possiede le caratteristiche della contro-informazione o della dis-informazione. L’altro strumento è certamente più dispendioso e complesso da mantenere, ma è molto più efficace sotto il profilo della percezione che ne può avere un’opinione pubblica che non sia attenta e critica. Aggiungerei poi che il tema dell’informazione è il tema gemello di ogni conflitto sul campo.
Professore, come commenta i distinguo della destra italiana tra migranti economici e quanti scappano dalla guerra in Ucraina? Ci sono disperati di serie A e disperati si serie B?
Si tratta di una distinzione puramente ideologica. Non solo nostrana. Anche nell’accoglienza da parte dei paesi confinanti con l’Ucraina, abbiamo visto che questo distinguo è stato applicato.
Sul tema del respingimento, non credo abbia inciso l’urgenza dell’accoglienza; insomma non è mutata la percezione del primo perché influenzato dalla seconda.
Ci sono guerre “più guerre” di altre?
Si rimane sempre dell’idea che l’identità e l’alterità (me stesso e il diverso da me) siano talvolta contrattabili nella categoria “mediana” della similarità. Far scorrere il regolo della similarità verso ciò che è più assimilabile a me, o collocarlo a una maggiore distanza (a seconda delle ideologie o delle politiche nazionali o internazionali), rimane purtroppo uno dei temi scottanti, con i quali anche Europa non ha fatto bene i conti. Su tutto ciò c’è ancora molto da rimuovere e da ricostruire.
La guerra è nel cuore dell’Europa, come se ne esce? La sola via per far cessare il conflitto e scongiurarne di altri può davvero essere una nuova corsa agli armamenti?
Escludo per molte ragioni che quest’ultima opzione debba essere di principio la via percorribile. Perché si tratta di una scala con molti gradini, in cima alla quale dopo l’ultimo viene l’abisso.
Il riconoscimento della “ratio”, della misura, del rapporto, della mediazione che dovrebbe caratterizzare la specie animale umana ci dice che ci siamo affacciati più e più volte dalla finestra dell’apollineo. Vi abbiamo scorto giù l’abisso del dionisiaco, fatto di hybris, di follia, di bestialità cui noi stessi possiamo andare incontro, se ci sottraiamo volontariamente a perseguire con tenacia la prima strada.
C’è un rischio, immediato?
Dal momento che la soglia del dolore storico si alza sempre di più, il rischio al quale si va incontro alla lunga è intanto quello dell’assuefazione, vestire il male dei panni della scontatezza o della normalità e, persino, come è stato detto, della “banalità”.
Ci dice quale ruolo secondo lei ha oggi la diplomazia, è ancora uno strumento?
Un approccio razionale non può che perseguire sempre la via diplomatica, ascrivibile, credo, non a tendenze pacifiste o pacifiche generalmente concepite (le quali partono da punti di vista legate a visioni di principio), ma alla scelta di strade politiche di tipo “irenico”, differenti da quelle “polemiche”. L’etimologia ci suggerisce che sempre di politica si tratta, ma di una politica raffinata, non di urto, capace perciò di gestire grammatiche culturali, politiche, economiche, militari alla luce di posture che alla fine tendono a rendere possibile il desiderabile, per tutte le parti in causa. E nel contesto europeo di questo lavoro se ne dovrà fare tanto.
Questa è certamente una guerra molto raccontata, filmata, fotografata. La narrazione è al centro della scrittura e spesso della riscrittura della storia. Che tipo di narrazione vede coagularsi attorno a questi fatti?
Sin dall’inizio del conflitto si è capito da subito che le narrazioni che stavano per radicarsi erano due e di segno opposto: quella dell’attaccante e quella del resistente. Intorno a esse si è cercato di negoziare tutta una serie di significati per rafforzare o indebolire sistemi valoriali e credenze dell’una o dell’altra parte. Fortunatamente, questa vicinanza anche geografica e continentale, certamente favorita dalla presenza dell’informazione costante a tutti i livelli sul campo, ha permesso da subito di rendersi conto di come stavano realmente le cose. In altri casi, dove conflitti e guerre a bassa intensità hanno scritto e continuano a scrivere pagine di storia con il sangue, il tempo e i fatti scorrono via senza turbarci.
Perché oggi è diverso?
Nel caso di una guerra in Europa, la corta distanza ha marcato il limite netto tra ciò che poteva interessarci e ciò che poteva anche non disturbarci. Ovviamente, questo ragionamento si inscrive in un perimetro ben definito e riguarda quella che comunemente chiamiamo “opinione pubblica”.
C’è però un dato che mi sembra rilevante: l’Europa è uno dei pezzi pregiati del mondo, per le tante ragioni che credo sia superfluo richiamare. Fino a ora il suo coinvolgimento attivo in una guerra è stato sempre limitato ai singoli stati e con varie gradazioni interventiste, anche non tanto dissimulate. La narrazione più pericolosa che si possa mettere in piedi in questo momento, giustificata e alimentata da questo conflitto, è una corsa al riarmo europeo, vista come una “necessità” globale e condivisa. Naturalmente, sto ponendo la questione da un punto di vista assai diverso da quello politico-militare o strategico. Ma mi chiedo se questa nuova narrazione, che purtroppo ha già gettato le sue fondamenta, non cambi volto all’Europa, facendole perdere d’un tratto la sua ideale vocazione di terra “franca”, circoscrivendola con una linea rossa e scrivendoci dentro di nuovo “Hic sunt leones”. Due guerre mondiali non sono bastate a dimostrarci che è proprio la rinuncia a questa “caratteristica” belligerante a rendere il nostro continente unico al mondo?
In Europa, aggiungo, questa tradizione del riarmo non è socialmente e politicamente accreditata. Dal momento, però, che assistiamo ad azioni di investimento e di programmazione sul medio-lungo periodo, è evidente che anche dal punto di vista mediatico se ne stia apparecchiando una narrazione, affinché si accrediti rapidamente. Un simile innesco farà perdere all’Europa la sua caratteristica peculiare, che è quella che l’ha resa attrattiva per tanti decenni. Alla sua potenziale disgregazione (che molti auspicano dall’esterno), non desidererei che aggiungessimo un elemento insufflato dall’interno, edificando un luogo di pace ma riarmato fino ai denti.
Chiudiamo prendendo in prestito ancora una riflessione di Yuval Noah Harari. Abbiamo assistito al fallimento delle narrazioni tradizionali: quella fascista prima, quella comunista poi, e infine anche quella liberale.
Una delle caratteristiche principali delle narrazioni è che esse sono “paradigmatiche”. Saldano insieme le giustificazioni, il punto di vista su una realtà di riferimento e il modo in cui essa si desidera che venga percepita. Da molti anni si parla del “tradimento” delle grandi narrazioni. La questione del superamento della modernità a favore di una post-modernità o di una ipermodernità ormai si può considerare oggetto di storiografia. Tutto alla luce del paradigma della iperconnessione mediale si è sciolto come neve al sole ed è stato fagocitato e riplasmato.
Dalla politica alla scienza, all’economia e il discorso potrebbe allargarsi ancora, si è parlato di promesse non mantenute e di futuro non realizzato. Ma tutte quelle forme di adesione razionale che avrebbero dovuto rassicurarci e spingerci verso traguardi della storia mediamente desiderabili (e che di volta in volta si sono annunciate come il modello migliore cui guardare), di fronte allo tsunami della medialità si sono dovute rassegnare al ruolo di una subalternità, cercando di riparare in mare aperto ciò che rimaneva della loro imbarcazione.
Nel caso di quelle tre forme, sappiamo che dell’ultima (di quella liberale), se ne scorge qui e lì qualche brandello. Ma in questo caso il suo illanguidimento (diversamente dal crollo ideologico delle prime due), è stato dettato dalla contingenza di aver accolto al suo interno una lettura principalmente economicistica degenerata e priva di ogni regola etica. Paradossalmente è servita più a movimenti conservatori esterni alla tradizione liberale, per giustificare la salvaguardia di una posizione capitalistica aggressiva, che a essa stessa.
Chiediamo in definitiva al filosofo: come si vive in un’epoca di disorientamento, con le vecchie narrazioni andate in frantumi e nessuna nuova narrazione ancora emersa per sostituirle? Usciremo da questo guado, e come?
Allargando di molto la prospettiva, non dimentichiamo che “nell’oltre” di quelle tre forme, le narrazioni costruiscono qualcosa di più di una chiave di lettura “politica”. Esse sono l’acqua dove nuotiamo senza sapere che si tratti di acqua. In breve, perché tutto funzioni al livello più alto, nella narrazione non si deve dare un punto di vista esterno, di confronto. In fondo quelle tre narrazioni politiche hanno finito per coesistere e incrociarsi in un arco storico di contemporaneità. Si è quindi data la possibilità di leggerne una qualche messa a confronto e di conseguenza un attacco reciproco. Diversamente, le nuove narrazioni (e all’orizzonte se ne scorge già più di una) si sono adeguate ad assimilare categorie come quelle apparentemente ingenue di pop, ambient, confort-zone. Sono termini a prima vista neutri che prendo a prestito da altri contesti, per indicare il fatto che c’è bisogno ricreare innanzitutto perimetri nei quali la narrazione non venga percepita come afflittiva o pesante, perché collegata (come accadeva in passato) a stati di privazione, di libertà, di limite o addirittura di valori, ideali. Sono categorie, queste ultime in particolare, di tipo riflessivo e immediatamente non-disponibili. Oggi una narrazione desidera accreditarsi con i tratti dell’apertura immediata, della liberazione, della visione creativa, della meraviglia.
Come saranno, allora, le nuove narrazioni?
Le nuove narrazioni sono soft, morbide, nel senso che tenderanno sempre più a essere astoriche, o meglio tenderanno a separare la componente spazio-temporale della storia da quella della vita dei soggetti. Saranno sistemi inerziali nei quali dall’interno sarà difficile comprendere se si stanno muovendo, e verso dove, o se siano in quiete. Il mondo intero sarà capace di raccontarsi e rappresentarsi in una dimensione nella quale la pluralità dei bisogni sarà isolata dal corpo vivo della storia. Ecco, questo tipo di narrazione che già si è affacciata prepotentemente all’orizzonte, di fatto la stiamo vivendo, ed è quella messa a punto dalla ipermedialità. Da questa sarà difficile uscire fuori.
Con tutta probabilità, sarà l’ultima che dal punto di vista categoriale riusciremo ad agganciare alle precedenti, perché la sua trasformazione sarà rapidissima e serviranno altre attrezzature per comprenderne fino in fondo la portata.