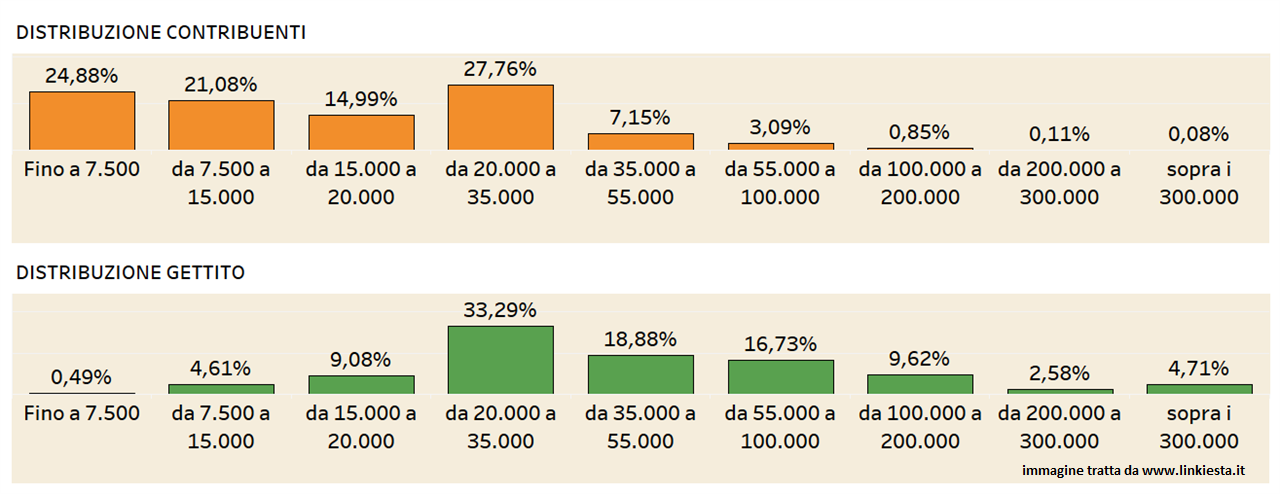Il 25 febbraio del 1956, dopo la conclusione del XX Congresso del Pcus, Krusciov pronunciò la sua requisitoria antistaliniana. Nel celebre rapporto segreto, Stalin viene accusato di aver alimentato il culto della personalità, snaturando lo spirito del marxismo-leninismo. Si attribuisce al dittatore la responsabilità di aver indebolito il partito e le forze armate, eliminando, in seguito ad accuse infondate, un gran numero di dirigenti e di ufficiali. La sua inadeguatezza come comandante viene considerata, inoltre, la causa principale delle gravi perdite subite durante la Grande guerra patriottica. Il rapporto rimane “segreto” fino al 4 giugno, quando viene pubblicato dal New York Times.
La svolta kruscioviana provocò una crisi profonda nel movimento comunista internazionale e in particolare nel Pci, in cui il culto staliniano era largamente diffuso. Una testimonianza evidente di questa liturgia ideologica si può trovare nelle parole con cui Palmiro Togliatti commemorò il dittatore sovietico, alla Camera dei Deputati, in occasione della sua morte. Lo descrisse come “un gigante del pensiero”. Ogni volta che si compie un atto che può assicurare la pace, proseguì, “ivi troviamo Stalin”. In quella stessa occasione, L’Unità apriva con questo titolo: “E’ morto l’uomo che più ha fatto per la liberazione del genere umano”.
Togliatti, che aveva preso la cittadinanza sovietica ed era stato vicesegretario del Comintern, aveva sempre dimostrato la sua fedeltà alle direttive del Pcus. Quando, al suo rientro in Italia, dà un nuovo volto al partito, con la “Svolta di Salerno”, esprime in realtà un orientamento concordato con lo stesso Stalin. Come ha scritto Silvio Pons, le decisioni assunte dal Pci, tra il 1944 e il 1948, furono “subordinate alla politica estera dell’Urss”. Al non intervento delle potenze occidentali nell’Europa dell’Est, lasciata sotto il rigido controllo sovietico, non poteva che corrispondere, infatti, un non intervento sovietico in Europa occidentale, come sarà definito nella Conferenza di Jalta, nel 1945.
Dopo la morte di Stalin, nel marzo del 1953, il potere fu retto da Malenkov, Krusciov e Berija. L’eliminazione di quest’ultimo e l’allontanamento di Malenkov, consentirono a Krusciov di assumere il pieno controllo del partito. Ebbe inizio, così, un processo che avrebbe condotto al XX Congresso. Le “aperture” di Krusciov alimentarono nel mondo socialista speranze “liberali”, che non tardarono a dar luogo a manifestazioni in cui si richiedeva a gran voce una maggiore partecipazione alla vita politica, al di là dei rigidi protocolli di partito. Dopo i disordini che si verificarono a Budapest, in seguito alla morte di Stalin, nel 1953, la dirigenza sovietica decise di affidare allo stalinista Rakosi la guida del partito e di chiamare al governo un moderato, come Nagy. Le sue scelte politiche, accusate di introdurre metodi liberali, comportarono però, nel 1955, un ritorno all’ortodossia, con la nomina di Hegedus.
Dopo il XX Congresso, le proteste popolari si diffusero e da più parti fu richiesto un processo nei confronti dello stalinista Rakosi e dei dirigenti del partito. Fu inoltre invocato il ritorno di Nagy. Il 23 ottobre, durante uno sciopero di solidarietà per gli insorti polacchi, venne abbattuta la statua di Stalin e fu assaltata la sede della radio. L’intervento militare sembrava la soluzione più prossima, ma prevalse la linea della mediazione. Nagy viene allora richiamato, ma la sua scelta di essere solidale con la protesta e di dimostrarsi favorevole al multipartitismo non può rassicurare il Pcus. Per i sovietici, ha scritto Tony Judt, la vera minaccia non era rappresentata dalla liberalizzazione dell’economia o dalla attenuazione della censura. Ciò che il Cremlino non poteva tollerare era la rinuncia al “ruolo guida del partito”, perché ciò sarebbe divenuto “un cuneo democratico”, fatale per tutti i paesi del blocco socialista, favorevoli, infatti, all’intervento, a parte la Polonia.
Il 30 ottobre prende vita un governo che vede, insieme ai comunisti, anche i socialdemocratici e altre piccole formazioni. Dai documenti attualmente disponibili, dopo l’apertura degli archivi sovietici, emerge, hanno scritto Elena Aga Rossi e Viktor Zaslavsky, che il 30 ottobre il Presidium del Comitato Centrale aveva deciso, all’unanimità, di non intervenire militarmente e di adottare, come sosteneva Krusciov, “il corso del ritiro delle truppe e dei negoziati al posto del corso militare”. Fu allora accolta con sorpresa la scelta dello stesso Krusciov di riconvocare il Presidium il 31, sostenendo la necessità di “restaurare l’ordine in Ungheria”.
Nel rapido mutamento di opinione da parte di Krusciov pesò sicuramente, secondo Aga Rossi e Zaslavsky, la posizione di alcuni leader del blocco comunista favorevoli all’intervento ed ebbe un ruolo non secondario un telegramma di Togliatti. Togliatti, definito dai due storici uno stalinista moderato, non condivideva il rigido stalinismo di Molotov, ma non si identificava neanche con quei “riformatori” che, come Krusciov, “stavano minando le fondamenta del blocco comunista internazionale”. Questa sua posizione “lo rendeva un interlocutore privilegiato all’interno della dirigenza poststaliniana”. Nel suo telegramma, inviato il 30 ottobre, le vicende ungheresi venivano descritte come “rivolta controrivoluzionaria”. Per evitare che i disordini alimentassero una deriva reazionaria, si rendeva necessario, a suo avviso, assumere una posizione netta. Le divisioni che, a causa dei “Fatti d’Ungheria”, si stavano creando all’interno del Pcus, del Pci e degli altri partiti comunisti, rischiavano, secondo Togliatti, di compromettere l’unità del movimento.
Nella risposta del Presidium a Togliatti, del giorno dopo, si esprime una totale condivisione con la sua analisi, e si evidenzia che non esistevano contrasti nella leadership del Pcus, che “unanimemente valuta la situazione e unanimemente prende le decisioni opportune”. In Unione sovietica, commentano Aga Rossi e Zaslavsky, il telegramma di Togliatti fu utilizzato in chiave propagandistica, per legittimare la soluzione militare. Quando, il 4 novembre, i sovietici entrano in Ungheria, il Pci si schiera a fianco dell’Urss, ritenendo che la rivolta avrebbe condotto alla guerra civile se non fosse stata prontamente sedata. Dopo l’invasione sovietica, Nagy, che si era rifugiato presso l’ambasciata jugoslava, fu prelevato dai sovietici il 22 novembre, nonostante Kadar gli avesse garantito un salvacondotto. Sarà poi impiccato nel 1958.
Il 4 novembre del 1956 è il giorno della rielezione di Eisenhower. Alla Casa Bianca, la questione viene presa in esame solo tre giorni dopo, ed è subito collocata in un quadro internazionale segnato, in quel momento, dalla crisi di Suez. L’opinione generale, ha scritto Judt in Postwar, “da Eisenhower in giù, era che fosse stata tutta colpa dei francesi e degli inglesi. Se, infatti, non avessero invaso l’Egitto, l’Urss non avrebbe avuto l’opportunità di muoversi contro l’Ungheria. L’amministrazione americana aveva la coscienza pulita” e gli equilibri della guerra fredda non sarebbero stati alterati.
Il tono del telegramma di Togliatti esprimeva un orientamento largamente condiviso nel partito. Giancarlo Pajetta scrive il 28 ottobre, su L’Unità, che era necessario reprimere gli attacchi al socialismo, per difendere i principi senza cui il capitalismo e il fascismo avrebbero trionfato. Il 30, sempre su L’Unità, Togliatti riconosce che i dirigenti non hanno compreso adeguatamente il disagio di ampi settori delle società socialiste, ma ciò non può giustificare la violenza dei “controrivoluzionari” di Budapest.
Non mancarono, tuttavia, le posizioni critiche, come dimostra il dissenso del segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio. Il 27 ottobre, su L’Unità, veniva infatti pubblicato un documento in cui, pur accogliendo la tesi togliattiana, secondo cui si potevano ravvisare, negli eventi ungheresi di quelle giornate, infiltrazioni reazionarie, la Cgil deplorava l’intervento militare. Le rivendicazioni dei ribelli, considerate di carattere sociale, venivano descritte come richieste di libertà e di indipendenza, che non potevano affatto essere viste come tentativi di restaurazione del regime fascista dell’ammiraglio Horhy. Il dissenso da Mosca e dalla linea togliattiana non riguardò, ovviamente, solo la Cgil. Antonio Giolitti ed Eugenio Reale, ad esempio, abbandonarono il partito e autorevoli rappresentanti del mondo della cultura espressero il loro dissenso nel Manifesto dei 101, in cui sostennero che i partiti comunisti avevano il compito di promuovere la democrazia e di condannare dunque lo stalinismo. Tra i 101 troviamo Asor Rosa e Melograni, Sapegno e Spriano, Colletti e Caracciolo, solo per fare qualche nome.
Il documento, diffuso dall’ANSA, produce scompiglio in casa comunista e gli eretici vengono convocati da Pajetta, da Bufalini, da Alicata, perché si convincano a tornare sui loro passi, come avviene nel caso di Spriano o di Cafagna, e di quanti prenderanno le distanze da quelle posizioni. Nella serata del 29 ottobre quattordici dei firmatari, ricorda Nello Ajello, inviano una lettera all’Unità, in cui dichiarano che chi ha fornito a “un’agenzia di stampa borghese” il testo della dichiarazione, finalizzata a “un dibattito interno al partito”, ha carpito la loro “buona fede”. Tra i fedelissimi, che si schierano a difesa di Togliatti, si distinse il latinista Concetto Marchesi, il quale, riguardo all’insurrezione ungherese, scrisse che un popolo non può rivendicare la libertà “tra gli applausi della borghesia capitalistica”.
In un suo articolo su la Repubblica del 2 febbraio 1996, Il brindisi di Togliatti, Gianni Rocca scriveva che il Migliore aveva scelto la “fedeltà a oltranza” con “il centro propulsivo” della rivoluzione mondiale, seguendo l’antico riflesso condizionato dello stalinismo senza riserve. Aggiungeva poi che Pietro Ingrao, allora direttore de L’Unità, ricordava, a quarant’anni di distanza, di essere rimasto “turbato” quando seppe dell’invasione e di aver sentito il bisogno di condividere con Togliatti il suo stato d’animo. Il turbamento dovette però divenire più intenso, quando si sentì rispondere dal suo segretario: “Io invece, oggi, ho bevuto un bicchiere di vino in più”.
Una opposizione particolarmente dura si ebbe da parte di un gruppo di collaboratori della Casa editrice Einaudi, che propose di sostituire, alla segreteria del partito, Togliatti con Di Vittorio o Giolitti, per segnare una frattura netta con i metodi stalinisti, che avevano caratterizzato una linea politica asservita a Mosca. L’VIII Congresso del Pci, del dicembre del 1956, diede agli eretici l’opportunità di esprimere in modo chiaro il proprio dissenso. Abbandonarono così il partito Calvino, Caracciolo, Melograni, De Felice, Mieli e altri. Il pentimento di Napolitano sulla tomba di Nagy, come i ripensamenti di Ingrao e di tanti altri, hanno rappresentato certamente l’esigenza di rileggere in maniera critica le vicende ungheresi. Hanno però confermato, al tempo stesso, l’incapacità di aprirsi, in quel momento, all’opzione socialdemocratica, incapacità che ha congelato le grandi potenzialità presenti nel Pci. È emblematico che ciò non fosse ancora chiaro nel 1981, quando, di fronte alla crisi irreversibile del socialismo reale, che avrebbe condotto al crollo del 1989, Enrico Berlinguer si limitava a commentare che la capacità propulsiva di rinnovamento delle società socialiste era “venuta esaurendosi”.
Testi citati
Judt, Postwar. La nostra storia, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2017.
A. Rossi- V. Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il PCI e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca, il Mulino, Bologna, 1997.
Pons, L’Urss e il Pci nel sistema internazionale della guerra fredda, in R. Gualtieri (a cura di), Il Pci nell’Italia repubblicana, 1943-1991, Carocci, Roma, 2001.
Ajello, Intellettuali e PCI. 1944/1958, Laterza, Roma-Bari, 1979.
È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.