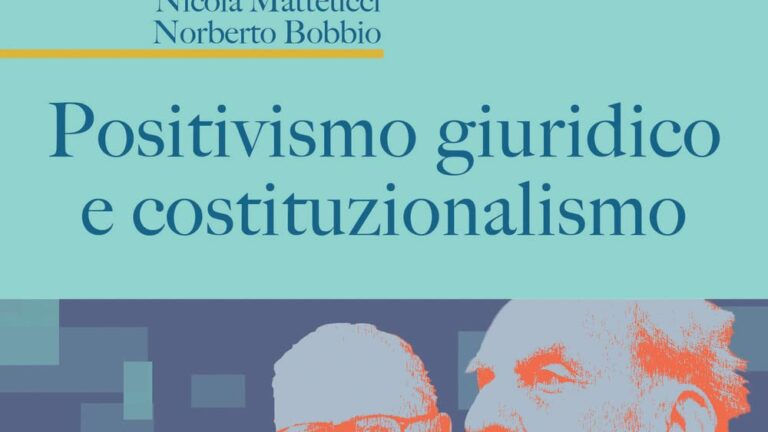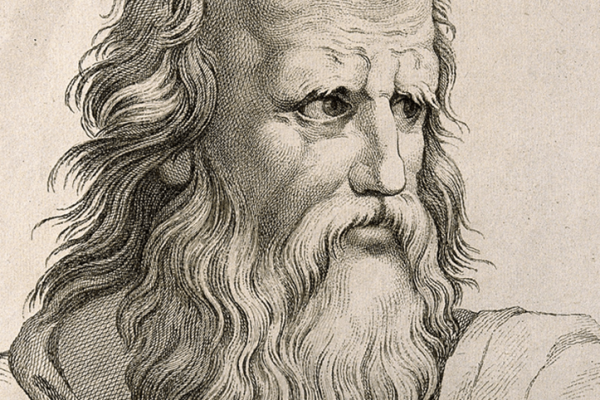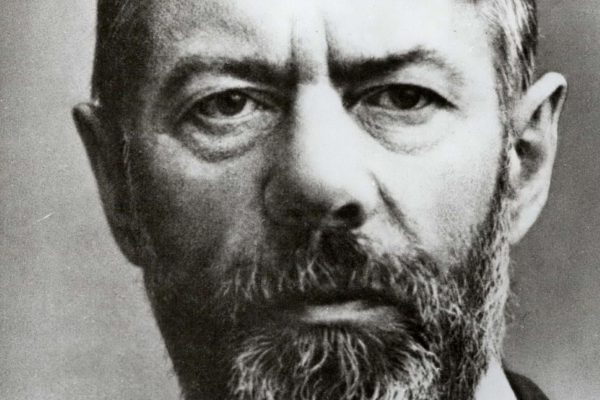Nel 1963 Nicola Matteucci pubblicò, sulla “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, il saggio Positivismo giuridico e costituzionalismo, in cui individuava, nella concezione che identifica lo Stato come unica fonte del diritto, il principale ostacolo alla piena realizzazione di una democrazia costituzionale.
Nell’argomentare la sua tesi, Matteucci assunse una posizione critica verso il giuspositivismo e Norberto Bobbio in particolare, che gli rispose in forma privata. Il saggio di Matteucci e la lettera di Bobbio sono stati poi pubblicati in Nicola Matteucci-Norberto Bobbio, Positivismo giuridico e costituzionalismo, Scholé, 2021. Nella sua introduzione, Tommaso Greco scrive che il testo di Bobbio rappresenta “un lavoro tra i più importanti della teoria giuridica e politica italiana della seconda metà del Novecento” e cita il giudizio di Polo Grossi, che lo considerò “un saggio preveggente”.
Il concetto di sovranità ha un suo radicamento nello Stato assoluto, che prese forma nell’Europa moderna.
Nella società inglese si consolidarono invece le consuetudini del diritto comune medioevale che, insieme alla tradizione giurisprudenziale, favorirono lo sviluppo del costituzionalismo. Nell’assolutismo, Regis volutas suprema lex, nel costituzionalismo, sottolinea Matteucci, Nihil aliud potest rex in terris, nisi id solum quod de iure potest. Se nel primo caso la legge è imposta dal sovrano, nel secondo definisce i confini della sua azione politica.
Il “pericoloso dogma dello Stato nazionale sovrano”, come ha evidenziato Grossi in Oltre la legalità, appariva a Matteucci incompatibile con la complessità dei sistemi “costituzional-pluralistici” che si affermarono dopo il tramonto dell’assolutismo, il cui “monismo giuridico” metteva in ombra le dinamiche sociali. La giuridicità, commentava Grossi in sintonia con Matteucci, diveniva quindi il “frutto esclusivo del laboratorio statuale”. Per Matteucci “una cosa è affermare che il diritto non può esistere che in forma positiva, altro è sostenere il monopolio del sovrano nella produzione giuridica”. La pretesa neutralità del modello positivista viene meno, peraltro, nel momento in cui non incarna, come potrebbe sembrare, una astratta legalità, ma “quella particolare legalità di cui è arbitro lo Stato sovrano”.
Nella sua risposta, Bobbio contestava la linea interpretativa di Matteucci, che tendeva a far coincidere positivismo giuridico e statalismo. Considerava inoltre debole la tesi dei teorici del costituzionalismo, che attribuivano al diritto la funzione di difendere il cittadino dal potere, dimenticando che il diritto è esso stesso, scriveva, una forma di potere, esercitata dai giudici. Difendeva poi il suo approccio scientifico e avalutativo e definiva ideologica l’impostazione di Matteucci, che avrebbe considerato i sistemi politici in rapporto alla conformità ai valori liberaldemocratici, condannando i regimi che se ne discostavano.
Come ha rilevato Greco nella sua introduzione, Bobbio si dimostrò in seguito consapevole del rischio di una riduzione del diritto a forza e, nei Saggi per una teoria generale del diritto, definì norme “per eccellenza” quei principi che stanno al di sopra di un ordinamento giuridico. In questa direzione, Bobbio dimostrava di avvicinarsi in qualche modo alle posizioni di Matteucci, riconoscendo che, in determinate circostanze, era necessario confrontarsi con questioni metagiuridiche, proprie del giusnaturalismo e del costituzionalismo, non più solo con regole. Ci si trovava allora “nella necessità di fare scelte valutative”.
Dopo il 1945, i moniti del giusnaturalismo avevano fatto breccia tanto tra i giuspositivisti quanto tra gli storicisti, come dimostra La restaurazione diritto di natura del crociano Carlo Antoni. In quel clima, Piero Calamandrei scriveva su “Il Ponte” che l’idea secondo cui ciò che lo stato permette, o addirittura premia, non è un delitto, avrebbe potuto trasformare in eroi i criminali nazisti processati a Norimberga. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 avrebbe poi dato una risposta a questo bisogno di giustizia, in quanto l’umanità finiva di essere una “vaga espressione retorica” per fondare un nuovo ordinamento giuridico. Le Carte nate dopo il 1945, positivizzando questi diritti, coniugarono le leggi di Antigone, invocate da Calamandrei, con la sacralità laica del costituzionalismo.
La Corte Costituzionale assumeva così il ruolo di “custode” della legge fondamentale, una “custodia” che, come è noto, non fu accolta con favore da chi temeva che vincolasse l’autonomia dei parlamenti e dei governi. Matteucci non manca infatti di rilevare che se per Alfonso Tesauro, ad esempio, questa funzione non trovava “alcun fondamento nella realtà della Costituzione”, per Calamandrei, al contrario, era necessario “difendere la Costituzione proprio dai possibili attentati del Parlamento”. Quando, come accade oggi in alcuni paesi europei, in Israele o negli Stati Uniti, il potere politico pretende di imbrigliare le Corti, vengono negati i principi del costituzionalismo e si spiana la strada alle democrazie illiberali, frutto di quella “insorgenza populista” che Matteucci aveva già individuato negli anni Settanta del secolo
È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.