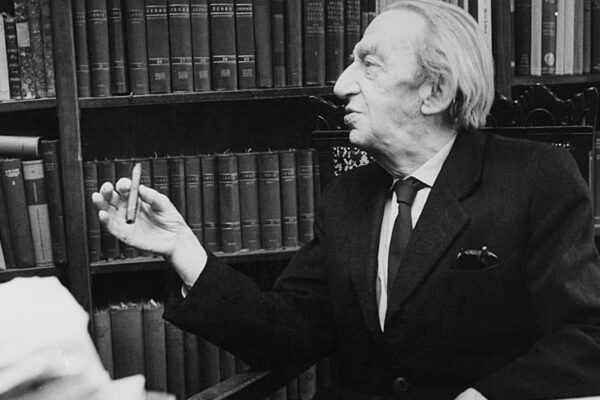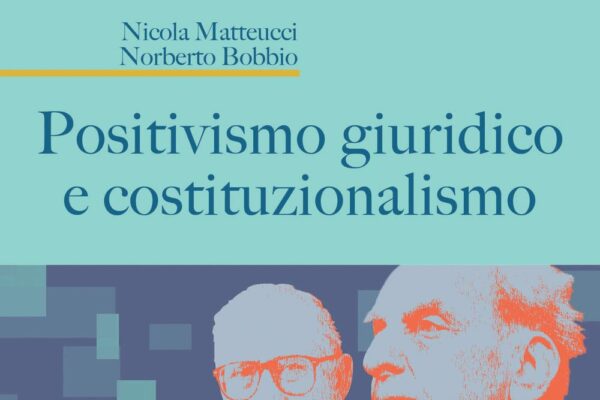Joseph de Maistre pubblicò Il Papa, la summa del suo pensiero, nel 1819, quando, nel clima della Restaurazione, gli echi dell’Illuminismo e della Rivoluzione sembravano lontani. Il testo riappare in libreria nella traduzione di Aldo Pasquali, Luni editrice, 2025. L’infallibilità nell’ordine spirituale e la sovranità, in ambito temporale, rappresentano, per de Maistre, “due perfetti sinonimi”, in quanto esprimono il sommo potere “che governa e non è governato, giudica e non è giudicato”. Come scrisse Carl Schmitt, per de Maistre lo Stato e la Chiesa, si caratterizzano per la capacità di prendere decisioni inappellabili. La sovranità politica riflette, sul piano temporale, l’infallibilità che la Chiesa riveste nell’ambito spirituale. La sovranità rifiuta, infatti, il controllo di una istituzione che la sovrasti, in quanto attribuisce a sé stessa un valore assoluto. I papi si sono spesso contrapposti ai sovrani, ma non hanno mai messo in discussione la sovranità, anche quando hanno sciolto i sudditi dal vincolo di fedeltà al re o all’imperatore, la cui autorità solo il pontefice poteva sospendere. La Chiesa è così riuscita a condannare i sovrani che si sono resi colpevoli di crimini, senza alterare, nello spirito dei popoli, sostiene de Maistre, “l’idea alta e sublime che dovevano avere dei loro padroni”.
Ogni governo che pretenda di fondarsi su una legislazione positiva, concepita esclusivamente come un sistema di norme poste dagli uomini, rappresenta, per De Maistre, una profanazione della legge divina. Opporsi al principio di autorità, alla maniera degli illuministi, condurrebbe allo sconvolgimento delle basi tradizionali della convivenza sociale, diffondendo la “malattia” dell’ateismo. Il governo è da lui inteso, infatti, come una vera e propria religione, che ha i suoi dogmi e i suoi sacerdoti e sottoporre il potere politico a un controllo da parte dei sudditi significherebbe svuotarlo del suo significato.
Nella teologia politica di de Maistre, la fede si rivela autentica quando rifiuta di mettersi in discussione, come avviene quando si accetta senza riserve la monarchia ereditaria, la guerra, o anche il matrimonio, che persistono nel tempo in quanto si sottraggono alle confutazioni della ragione. Solo ciò che trare origine da un fondamento irrazionale ha la garanzia di resistere all’attacco della ragione, che, con la sua critica corrosiva, tende a distruggere anche quel che essa stessa costruisce. Coerentemente con queste premesse, de Maistre, durante la sua permanenza a Pietroburgo, consigliava al principe Aleksandr Golicyn, direttore secolare della Chiesa ortodossa russa, di limitare l’insegnamento scientifico, per arginare lo scetticismo e l’individualismo, che avrebbero favorito i movimenti di emancipazione. La mentalità scientifica individua le cause dei fenomeni nelle leggi necessarie della fisica e induce ad abbandonare la preghiera, “il respiro dell’anima”,
come si legge nel quarto colloquio in Le serate di Pietroburgo. Nell’ottavo colloquio, il Senatore, che sostiene le idee di de Maistre, giudica le teorie fisiche come “dottrine insolenti che rozzamente giudicano Dio e gli chiedono conto dei suoi decreti”, e accusa gli scienziati, sempre più influenti e numerosi, di essere “una corporazione, una folla, un popolo”. Per de Maistre non è compito della scienza guidare gli uomini, in quanto “spetta ai prelati, ai nobili, ai grandi ufficiali dello stato essere i depositari e i guardiani delle verità conservatrici, insegnare alla nazione qual è il male e qual è il bene, ciò che è vero e ciò che è falso nell’ordine morale e spirituale; gli altri non hanno diritto di ragionare su simili materie”. Nei confronti di chi, coltivando il pensiero critico, contribuisce a “togliere al popolo un dogma nazionale”, la condanna di de Maistre è capitale: “deve essere impiccato come un ladro qualsiasi”.
Il richiamo di de Maistre alla fede, come cardine di un ordinamento politico, può farci comprendere la struttura di un regime totalitario, in cui non vi sono cittadini ma sudditi e ogni decisione è affidata al capo carismatico, con il quale la massa è chiamata a identificarsi in una sorta di unione mistica. Ecco perché Isaiah Berlin attribuisce a de Maistre la responsabilità di aver fornito efficaci strumenti ai movimenti reazionari che, fra le due guerre, hanno preparato il terreno all’affermazione delle ideologie totalitarie. Una società sarà stabile, per de Maistre, solo se sottomessa a una autorità assoluta, dal momento che porre limiti al potere può agevolare la formazione di movimenti rivoluzionari.
Ostile all’ottimismo e al razionalismo illuminista, de Maistre elaborò, con coerenza, una concezione radicalmente pessimistica della natura umana, segnata dal peccato originale. Nell’espressione “Dio degli eserciti”, che “brilla” nella Sacre Scritture, emerge per lui una profonda verità, in cui la guerra costituisce la legge generale dell’universo. Si tratta di una forza insieme “nascosta e palpabile”, che appare evidente nel regno animale e che non si arresta di fronte all’uomo, incessantemente in conflitto con i suoi simili. Ogni individuo si trasforma, in combattimento, in un omicida innocente, compiendo gesta che, in situazioni diverse, lo farebbero inorridire. Agisce infatti, in lui, una volontà che lo governa senza che egli stesso ne sia cosciente. Il fatto che siano rarissimi i casi di ammutinamento, anche quando si combatte per un sovrano che non si ama, dimostra la natura irrazionale della guerra, in cui l’istinto primario dell’autoconservazione viene quasi messo a tacere, e si rischia la vita per combattere contro nemici sconosciuti, verso i quali, al di fuori del campo di battaglia, non si avrebbe alcun motivo di rancore. Nel mettere a confronto il soldato e il boia, de Maistre immagina lo stupore di un ipotetico essere extraterrestre che si trovasse a osservare l’ammirazione che circonda i militari, impegnati a uccidere dei loro simili onesti e l’abiezione verso il boia, chiamato a dare la morte a dei criminali. L’extraterrestre non potrebbe che tributare al boia grandi elogi, commenta de Maistre, dal momento che sono rare le guerre giuste, mentre le esecuzioni capitali, simbolo del rispetto della legalità, rappresentano il giusto esito di una condanna con cui si è concluso un processo.
Attraverso la guerra e la cieca ubbidienza alle sue regole, si realizza allora, in modo irrazionale, “la grande legge della distruzione violenta degli esseri viventi”, una legge che de Maistre definisce “divina” e di “ordine soprannaturale”, le cui conseguenze risultano poco conosciute, nonostante siano, a suo avviso, incontestabili.
Il nostro secolo, scrive, “non è ancora maturo per occuparsene: lasciamogli la sua fisica e intanto teniamo gli occhi fissi su questo mondo invisibile che spiegherà tutto”. Il rifiuto di de Maistre della ragione illuminista è evidente in ogni passo delle sue opere, nella polemica contro il contrattualismo, il mito del “Buon selvaggio”, le concezioni universalistiche dei diritti umani. Nel corso della sua vita, scriveva polemicamente, aveva incontrato francesi, italiani, russi, e, grazie alle Lettere persiane di Montesquieu, qualche persiano, ma non aveva mai incontrato l’“uomo”, inteso come cittadino del mondo. L’idea che la ragione governi la vita degli uomini è per de Maistre una grande illusione, in quanto l’umanità, corrotta dal peccato originale, è incapace di darsi quell’ordine stabile che può essere garantito solo dalla Chiesa e dal Papa, la cui infallibilità non è scalfita dai sofismi dei filosofi e degli scienziati. Le argomentazioni di de Maistre contro lo spirito del
suo tempo presentano un carattere fortemente conservatore, rivolto a un passato che risultava impossibile riportare in vita, ma consentono anche di confrontarsi con una visione del mondo che rifiuta quell’abuso della ragione”, denunciato, in forme diverse, da Friedrich von Hayek come da Karl Popper, nel corso del Novecento. Ecco perché Isaiah Berlin ha scritto che de Maistre, di fronte a tanti suoi contemporanei progressisti, “è in effetti ultramoderno”. E’ riuscito, infatti, a cogliere le fragilità del progetto illuminista e, pur prospettando soluzioni impraticabili, ha svelato le strategie delle visioni totalitarie che, in forme diverse rispetto a quanto è già accaduto nel Novecento, minacciano oggi le democrazie. Negli anni Cinquanta del secolo scorso, durante la Guerra fredda, in una conferenza radiofonica trasmessa dal terzo programma della BBC, Berlin collocò de Maistre fra i “traditori della libertà” e tra i precursori del fascismo. Riconobbe però, ironicamente, che la libertà ha bisogno dei suoi critici oltre che dei suoi fautori. Studiando le strategie dei “nemici” della libertà, come ha fatto Berlin, possiamo capire come difendere le società aperte da quanti,
imponendo modelli autoritari, vorrebbero trasformarle in autocrazie.
È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.