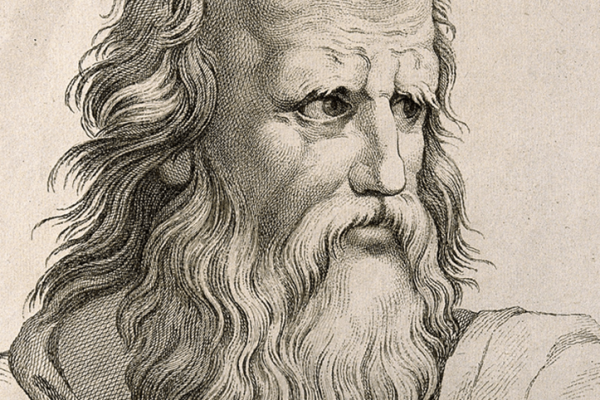Dalla riflessione capitalistico-esistenziale marquardiana al raccoglimento agostiniano
La ritmicità della a noi coeva realtà poggia su una chiave di violino il cui ritmo batte scandito dall’andamento economico che, si dice, armoniosamente coincide con istanze di matrice sociale. Il pentagramma delle relazioni sociali che si fondano nella contemporaneità suona allegramente una melodia indeterminata tendente verso un telos poco chiaro che, per questo, sembra fare della sua sensatezza finale lo stesso momento – più o meno consapevolmente intrapreso – del cominciamento, fuggente e repentino; la sintomatologia per la quale stesse realizzandosi un’umanità ancora più inestricabilmente interconnessa alla struttura economica – della quale diagnosi l’attribuzione va data a Marx (cfr. K. Marx, Per la critica dell’economia politica, Lotta Comunista, Milano, 2009) –, infine, vede la sua esacerbazione in una monoliticità di costumi omogeneizzati e dissolventi l’integrità singolare ed unica dell’individuo (vedi sul tema Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari, 2011).
In un panorama sì sviluppato dell’umano, evidentemente capitalista – in senso, vogliamo specificare, neutro ed oggettivo –, la maniera dell’impellenza e della velocizzazione del quotidiano (e non solo della produzione) diviene protagonisticamente centrale rispetto ad una qualsivoglia riflessione intorno alla condizione dell’uomo. La revisione e ricostruzione filo-capitalistica dell’umanità rifunzionalizza lo scheletro ontologico dell’individuo rendendolo un esibizionista di sé, ricercante, ora, l’adeguazione al sociale – nonché l’apprezzamento; laddove, prima, dell’umano si trattava mediante la categoria letteraria del dramma (cfr. F. Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, Bompiani, Milano, 2019), ad oggi questi viene raccontato attraverso quella dello spettacolo (vedi G. Debord, La società dello spettacolo, Massari editore, Bolsena, 2002). Sempre con maggiore intensità l’uomo si istituisce – se non ancor più pessimamente istituzionalizza – in quanto persona di sé esponendo, così, per quanto testé detto, una preconcetta e posticcia costruzione del proprio soggettivo che, infine, tende solo alla spettacolarizzazione di quanto si possegga o – meglio, schopenhauerianamente (A. Schopenhauer, Aforismi per una vita saggia, RCS Libri S.p.A., Milano, 1997) – di quanto si sia, avendo quanto si abbia.
L’autentica soggettività, quella che si fonda ed è poggiantesi sulla propria individuale ed irripetibile espressività, tramonta in un grande meriggio la cui alba successiva scoperchia solamente l’insignificazione del collettivo indifferenziato che, con fare bulimico, fagocita ed assimila le varie singolarità (cfr. S. Weil, La persona e il sacro, Adelphi, Milano, 2012). L’odierna considerazione dell’esistenza dell’uomo si esprime non più mediante l’egoità, bensì, patologicamente, mediante il noi che, però, in-sé, è bi-dimensionalmente svuotante la tenuta autentica di ogni tridimensionale – e tendente all’infinito – individualità desiderante di realizzarsi nella sua unicità. Diventa così evidente che la vera impellenza del contemporaneo – quasi come prima non fosse altrettanto –, riguarda, più che la considerazione dell’umano, la sua stessa considerazione della sua autenticità di sé che poi, certamente, rimanda una seducente eco percuotente la sua condizione di uomo nel reale esistente. In altre parole, dapprima che egli si pensi nella sua stessa esistenza, e nella sua esplicitazione di sé che dovrebbe, perlomeno auspicabilmente, fondarlo autenticamente rendendolo sé stesso, è necessario che si ripensi in-sé e si ricostituisca determinatamente riaffermandosi solidamente in quanto sé stesso. Quanto ancora può dirsi – e può, addirittura, ancora dirsi qualcosa – dell’umano in una situazione sia ontologica, sia storica, sociale ed economica, in cui questi sta impegnandosi così alacremente nel rendersi cosa-di-sé-stesso?
Una diagnosi tanto rivelante una frammentazione dell’umano porta con sé, necessariamente, anche un’analisi intorno a quella che sia la maniera dell’uomo inscritto nel contesto in considerazione: se, marxianamente, ad ogni diversa configurazione economica corrisponde – seppure certamente non in modo rigidamente deterministico – una modalità dell’umano che su questa si sovrastruttura, è indessicale per noi, in quest’istanza, scrutare quanto attualmente l’uomo faccia significante di sé. Il discorso, però, credo debba spostare i suoi interessi da una centralità economicistica tipicamente marxiana ad una inclusione, quantomeno laterale, dell’ontologia: tra la struttura economica basale e la modalità dell’umano su questa stanziantesi, si dà inframezzo un punto credo decisivo di interconnessione riguardante lo statuto stesso delle individualità; queste, di fatti, non sottostanno propriamente ad una proporzione economica, ma con tinte variopinte, quasi misteriosamente ed abissalmente, si de-strutturano e ristrutturano a seconda di variabili tanto promiscue ed enigmatiche da rendere l’uomo davvero una sfinge. L’umanità, insomma, eccede sempre sé stessa, è sempre, puntando gli occhi ad Heidegger (Essere e tempo, §41sgg.), avanti-a-sé; figuriamoci, quindi, se possa inseguire l’andamento economico, realizzandosi proprio attraverso esso. L’eccedenza fa sempre più dell’incontrollabile la sua caratteristica fondativa tanto più il soggetto stesso si pone nella malaugurata situazione ontologica di separazione dalla sua individualità.
È proprio intendendo questo che Odo Marquard, nel 1981, propone, fortissimamente infatuato dalla filosofia heideggeriana – della quale, tra le altre cose, tenta una rilettura scettica –, in Apologia del caso (il Mulino, Bologna, 1991), una valutazione sinceramente inquietante dell’umano: quasi profeticamente intuendo quelle che potessero essere le conseguenze di una economia capitalista globalizzata sul senso dell’umano, sostiene, col concetto di tachiestraniazione, che dell’uomo contemporaneo si possa solo dire della sua fanciullezza (cfr. op.cit., pp.121sgg.).
Secondo l’autore non è, infatti, possibile alcuna maturazione anche solamente inerente una maggiore consapevolezza veniente dalla crescita anagrafica se la tecnica e le logiche iperattive del capitalismo rimescolano il mondo, anche e soprattutto materialmente, senza alcuna possibilità per l’umano di adattarsi e stabilizzarsi – «[…]là dove duemila anni fa c’erano un bosco e mille anni fa un campo e cinquecento anni fa una casa, c’erano centocinquant’anni fa una fabbrica tessile, settantacinque anni fa una stazione, venticinque anni fa un campo di volo ed oggi un terminale per i satelliti spaziali; cosa ci sarà fra dieci anni, non lo sappiamo ancora. […]Per questo, anziché diventare automi, e cioè adulti, attraverso la crescita costante dell’esperienza e della cognizione del mondo, noi scivoliamo vieppiù, nuovamente indietro nella condizione di coloro per i quali il mondo è, in prevalenza, ignoto, nuovo, estraneo[…]» (op.cit., p.124).
Disperso in questo mondo non accogliente, insicuro, io, della mia stessa quotidianità, e liquido in quelle che dovrebbero invece essere le mie solide certezze, sempre in agguato rispetto al repentinamente ed imprevedibilmente cangiabile; ora qui, ora lì – tutto intorno a me perde di consistenza e tutto appare immerso in una frenesia tachicardica scarnificante ed insulsa. La stessa superficie sulla quale poggio vacilla; il cielo a sua volta sembra frantumarsi, come fragilissimo e delicato vetro, facendo piovere uno spargimento di vuotezza che, con ignominia, infamia e colpevolezza, sembra velare qualsiasi cosa mi passi innanzi. Io stesso, infine, mi dissolvo, mi liquefo nella mia stessa sembianza di me che, ormai nulla ed infertile, è tutto quanto mi rimane; sempre fanciullo scoprente o tentante di scoprire il mondo e me; mai adulto autenticamente posizionato nella sua vita.
L’eccessiva velocizzazione del tutto porta con sé la drammaticità dell’estraniamento, dell’alienazione; lo scotto di logiche di produzione tanto pervasive non solo nell’ambito dell’economico, ma anche in quello dell’umano, è quindi, come intuibile, ripercuotentesi sulle singolarità che, appunto a causa di ciò, perdono la capacità di maturare sé stesse ed il mondo. È così chiaro che la più grande urgenza – non solo filosofica, ma assoluta nel suo abbracciare la purchessia ramificazione dell’umano in quanto tale – del nostro secolo, ed anche di quello scorso e forse dell’intera storia dell’umanità, sono le singolarità: gli individui, le soggettività in potenza di auto-determinazione.
La costituzione del soggettivo gioca un ruolo fondamentale soprattutto nel pensiero – a dire il vero per nulla sistematico, ma non per questo disordinato – di S. Agostino; la centralità della soggettività in-sé viene evidenziata soprattutto grazie ad opere come Le confessioni dove l’autore espone la sua assolutezza individuale a sé dandosi in modo ontologicamente immediato e puro. Non tanto l’umano è quindi ivi fondamentale, quanto l’individualità irripetibile – e questo è imprevisto ed inconsueto in un’epoca, quale quella medievale, le cui categorie epistemologiche e tassonomiche seguono ordinamenti ontologici inerenti raggruppamenti in macro-aree concettuali sempre più capienti. Seppure, dunque, nel medioevo sia la tensione all’universale a permeare il panorama conoscitivo ed ordinativo, con atteggiamento insulare ed originalità scintillante, dolcemente ed umilmente, onestamente, Agostino ridimensiona il tiro finendo però, guardandolo a rovescio, per potenziarlo incommensurabilmente: non in quanto ente ascrivibile ad una specie e ad un genere si considera, ma in quanto singolarità assoluta, finita e determinata; imperfetta ed esistenzialmente claudicante fossanche, ma cionondimeno solidamente affermantesi come egoità compiuta ed immediata.
Agostinianamente parlando, non è l’umano come astrattamente universale a custodire nell’animo – inteso come culmine semplice ed assoluto dell’integrità ontologica del singolo – la verità, ma è l’io, l’individualità che mi è propria, che ti è propria, a renderci conto dell’autenticità illibata e vergine della sensatezza dell’intero. Ed è infatti per questo che Agostino cede ad un lavoro come le succitate Confessioni, opera fortissimamente autobiografica, l’onore ed al contempo l’onere di farsi ricettacolo delle più fervide, effervescenti ed interessanti argomentazioni intorno alle più frizzanti e spinose tematiche, specie riguardanti il Cristianesimo. Tutta l’impostazione teoretica agostiniana, per quanto proteiforme e squisitamente poliedrica, mira ad una reintegrazione del soggetto rimettendolo alla sua stessa soggettività inalienabile, indissolubile, inestricabile, insopprimibile; ne La vera religione (XXXIX, 72), per ciò, esorta ad un ritorno nella propria intimità, perché solo dentro di noi ha asilo la verità: «Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas».
Sembra che, dunque, una risposta possibile alla marquardiana tachiestraniazione, sintomatica di un sistema economico rimescolante le carte dell’umano come tale, venga data dalla sempiternamente valida massima di S. Agostino: riassestarci in noi stessi per scoprirci o riscoprirci, per ricordarci di fare il senso, di rappresentarlo, di portarlo al mondo, di condividerlo e quindi, infine, di performare il vero; ciò che più manca, e che più mancando si fa d’altronde più dirompentemente presente nell’assenza che mantiene, è l’umano – e non solo: l’umano è disperatamente mancante di sé a sé.
Se davvero il problema dell’uomo è quello di non riuscire a starsene fermo in una stanza come dice Pascal (Pensieri, XXI, 2), è da ricercarsi allora non tanto una fissità esistenziale, una stagnazione ontologica, quanto un equilibrio armonioso con sé e col mondo che, infine, con poetica speranza, possa renderci felici di vivere e di essere-nel-mondo.
Nato nel 2001, attualmente studente presso la facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; si è occupato già di Filosofia presso numerose riviste e blog. Spiccano, tra le varie, le collaborazioni con “Gazzetta Filosofica”, “Filosofia in Movimento”, “Ereticamente — Sapienza” e “Pensiero Filosofico”. È stato membro della redazione della rivista “Intellettuale Dissidente”; ivi, si è occupato dell’etichetta “Filosofia”. Ha anche pubblicato per il blog “Sentieri della Ragione” e, sulla sua pagina Facebook (“Sentieri della Filosofia”), è stato relatore, con la direttrice, di due webinar aventi riscosso soddisfacente successo. Saltuariamente, pubblica i suoi contributi sulla piattaforma accademica “Academia.edu”; qui, questi hanno ricevuto — in totale — quasi una decina di migliaia di letture. Ha collaborato con l’editorial board di “Pillole di Ottimismo”, dando, della complessa e poliedrica questione pandemica, una contestualizzazione filosofica. Ha tenuto convegni di Filosofia locali presso la sua città d’origine, Bitonto — in collaborazione con la testata giornalistica del luogo, dal titolo “La Persistenza Filosofica”. Occasionalmente, pubblica anche per il blog di psicologia Italiano, “Psiche.org”. È stato membro della redazione, occupato nell’etichetta “Filosofia”, della rivista — ormai inattiva, “nuovoumanesimo.eu”. Infine, è stato chiamato a presentare un lavoro sul testo “Mobilitazione Totale” di M. Ferraris in occasione dell’evento “Summer School di Filosofia Teoretica” (2019) intitolantesi “Pensare il Futuro/Pensare al Futuro” tenutosi in Bitonto — al quale dibattito (oltre alla presenza dell’autore) ha partecipato il filosofo B. Stiegler.